Andrea Pubusa

E’ ben noto che dopo la fusione perfetta calò sui domini sabaudi la più mortifera cappa di centralismo, che durò, accentuandosi durante il fascismo, fino alla Repubblica e alla Costituzione. Non che il Regnum Sardiniae fosse un modello di autogoverno, ma esistevano gli stamenti (parlamenti cetuali), la Reale udienza, massimo organo giurisdizionale sardo con funzioni talora anche politiche, vigevano le leggi sarde (la Carta de Logu, anzitutto) per quanto datate, ed esistevano i trattati internazionali, vere leggi fondamentali, non modificabili dal sovrano, che assicuravano questo assetto. Su questi elementi Angioy costruì la sua idea di rilancio del Regnum, della statuaità sarda, ma la sua sconfitta portò in pochi decenni alla scomparsa del Regnum come entità a sé stante e avvio’ una lunga notte di accentramento.
Come spiegare allora l’esplosione meno di un secolo dopo dell’idea federalista dei combattenti sardi della Grande guerra? Com’è noto, la storia come la natura non fa salti. Qualche seme di quell’idea doveva aver attecchito o comunque non era andato completamente disperso. Ad onor del vero agli albori del sardismo veniva rivendicata l’autonomia, il termine federalismo non era ancora nel vocabolario sardista. Bellieni, per esempio nella sua appassionata relazione al Primo Congresso de combattenti sardi del maggio del 1918 non fa menzione del federalismo, si parlava piuttosto di “autonomia di tutti gli enti locali, con la limitazione dell’autorità politica al solo controllo“. Gli enti tuttavia potevano consorziarsi in unità più vaste, seguendo le suggestioni provenienti da Salvemini a dalla Scuola meridionalistica. Era infatti Salvemini ad affermare che le autonomie locali dovevano fondarsi non sulle Regioni ma sulle province, consorziandosi così da formare unità istituzionali più ampie. Le Regioni apparivano come entità più lontane e ancora da inventare, anche se non mancarono i fautori di queste.
In realtà, ad uno sguardo retrospettivo, in Sardegna l’autonomismo nelle sue diverse varianti più che da una consapevolezza nasceva da un sentimento, un sentimento che ha avuto punti alti di elaborazione e di pratica politica, che tuttavia hanno giocato più sul piano sentimentale che su quello della lascito culturale e programmatico. Dopo la breve epopea angioyana, l’idea federalista ha due esponenti di rilievo in Sardegna: Giovanni Battista Tuveri e Giorgio Asproni. Pur con diversa impostazione, non a caso sono entrambi fautori della sovranità popolare e della Repubblica e il feïlderalismo ha il suo fondamento proprio in una società pienamente democratica in cui il potere e la sua legittimazione promanano dal basso. Ecco perché il tema centrale dell’opera più celebre di Tuveri, “Del diritto dell’uomo alla distruzione dei cattivi governi”, è costituito dalla “difesa della sovranità popolare contro la sovranità del principe“; questo è il filo rosso che percorre tutta la storia del pensiero politico democratico, ma in Tuveri, pur nella sua ascendenza religiosa, gioca come cuneo per spezzare il soffocante centralismo statale dopo la fusione perfetta. Tuveri evoca i classici esempi di tirannicidio da Pisistrato, ucciso da Armodio e Aristogitone, e Giulio Cesare da Bruto, e richiama i teologi cui i monarcomachi, anche nel Medioevo si erano ispirati, ma certo lui aveva assorbito la lezione del nonno, Domenico Vincenzo Licheri, un importante funzionario del Regnum ai tempi di Giommaria Angioy e suo seguace, nella cui casa ad Oristano visse dopo la morte prematura del padre (L. Carta). Ma sul grande movimento antifeudale cadde non solo la repressione golpista, sproporzionata e terroristica dei Savoia e dei ceti privilegiati sardi nella ricerca spasmodica di mantenere, in quel mondo in rapida trasformazione, privilegi, prebende e potere, ma si abbattè con successo anche la damnatio memoriae imposta dai vincitori. Ancora oggi, per il valore dei simboli, al centro di Cagliari troneggia una gigantesco e grottesco monumemto a Carlo Felice e solo una via secondaria ricorda Giommaria Angioy!
Emilio Lussu, con la sua usuale eleganza ed efficacia, a proposito dei moti antifeudali culminati nella primavera del 1796 nei cento giorni dell’Alternos di Bono, sottolinea che questo “originale movimento“, “sorto per il propagarsi fra gli intellettuali sardi delle correnti ideologiche e politiche della rivoluzione francese divenne popolare e si batté contro i francesi. Di questo movimento che culminò nella rivolta contro i feudatari e al quale il movimento autonomista sardo del dopo-guerra si riallaccia direttamente, come il movimento socialista francese si riallaccia alla grande rivoluzione”, si è quasi persa memoria per tutto l’Ottocento. “Esso è ignorato in genere dagli italiani, eppure fu il primo movimento rivoluzionario affermatosi in Italia dopo la rivoluzione frnacese, di cui non era che una ripercussione, e fu antecedente a quello che condusse alla Repubblica Partenopea“. Anche “di Tuveri, - osserva Lussu - l’ultimo dei monarcomachi, amico di Cattaneo, che aveva studiato a fondo la questione rurale, arrivando alla conclusione delle necessità di una rivoluzione agraria, non rimaneva più nessuna traccia“. E tuttavia quelle lotte e quelle elaborazioni, come un fiume carsico, qualcosa hanno trascinato e portato alla luce se poi ci fu il sardismo. “La brigata Sassari principalemtne fu il deposito rivoluzionario della Sardegna del dopo-guerra”. “La guerra è stata per noi tutti, una grande lezione umana e nazionale. “Nazionale in senso sardo“. Sentimento, prima che acquisizione intellettuale. “Sentimmo cioè potente la nostra individualità con un sentimento unitario e autonomo con la coscienza per giunta di far cessare uno stato di oppressione e di sfruttamento. Sentimmo la capacità di essere noi sressi e niente altro che noi stessi: autogoverno. E il diritto di partecipare autonomamente alla trasformazione dello Stato italiano, il nostro Stato di tutti. E di essere di questo Stato soggetti sovrani di diritto“. Ecco che, gira, gira, riemerge il tema centrale della sovranità popolare, come in Tuveri, come in Asproni. “Tradotto in termini politici i più chiari possibili, ciò oggi vuol dire Federalismo“. “Questo sentimento nazionale…fu alla base e alle origini del movimento” sardista. E fu di tutti. “Tutti i socialisti, nessuno escluso, che fecero la guerra, entrarono, e alcuni come massimi esponenti, nel nostro movimento“. “Sarebbe temerario - azzarda Lussu - porci anche solo la domanda che cosa sarebbe avvenuto di Gransci se avesse fatto la guerra con noi“.
Sarà un caso? Anche Gramsci, benché non combattente, fu federalista e anche sardista.
Come Lussu - ci ricorda il compianto Francesco Cocco - “anche Antonio Gramsci seppe uscire dalle angustie di una sardità chiusa, senza per questo perdere ciò che di vitale gli veniva da un rapporto vissuto intensamente col suo mondo d’origine. La Sardegna, durante i lunghi anni di detenzione carceraria, finì per saldarsi nella sua mente con gli orizzonti emergenti dai grandi conflitti storici ed ideali dei primi decenni del Novecento.
Dall’inconcludente ribellismo paleo-sardista espresso dalla parola d’ordine “al mare i continentali!” che - come egli stesso ci racconta - lo attrasse nelle prime esperienze politiche sarde, Gramsci passa al faticoso cammino intellettuale per individuare i meccanismi che avevano generato e consentivano il mantenimento della dipendenza della Sardegna da forze esterne.
L’indipendentismo era stato il primo orizzonte istituzionale del giovane Gramsci che fa il pendant col suo provincialismo da villaggio. Al di là della ingenuità che vi si può leggere, vi era già allora qualcosa di vecchio risalente alla formazione degli Stati nell’Ottocento: una ricerca di sovranità statuale che si addiceva agli angioiani e post-angioiani a cavallo tra Sette e Ottocento più che ai nuovi orizzonti politici che un secolo dopo già cominciavano a guardare a processi di aggregazione soprannazionale. Ed infatti quando, dopo il primo conflitto mondiale, la questione sarda raggiunge un livello di maggior maturità, la soluzione proposta non è quella di “buttare al mare i continentali” ma rivendicare autonomia politica, il riconoscimento della propria soggettività di popolo nell’ambito della più ampia soggettività nazionale italiana.
In tale posizione certamente vi era il fascino, ancora intatto, della Rivoluzione russa del ‘17, (l’URSS come grande repubblica federale di nazionalità), ma soprattutto vi era la consapevolezza che occorreva andare oltre l’intelaiatura sabauda data agli stati preunitari nel processo di unificazione risorgimentale. E la ricerca che Gramsci portò avanti per un decennio in carcere è finalizzata a questo: analizzare lo società italiana in tutte le sue varie componenti per riaggregarla su più solide basi“.
Lussu ha colto ed apprezzato l’ispirazione federalista di Gramsci, che alla guida del PCD’I pose nel programma la costruzione di una Federazione delle Repubblivhe socialiste e soviettiste d’Italia, ma non lo convinceva la sua articolazione. La repubblica del Nord, la repubblica del Sud, la repubblica siciliana e la repubblica sarda gli parevano non rispondenti alla reale formazione delle comunità quali si erano venute storicamente sviluppando dopo la caduta dell’impero romano. Non contestava ovviamente la posizione riservata alla Sicilia e alla Sardegna, già antichi regni, ma la divisione del resto d’Italia in due entità Nord e Sud. Lui Lussu propendeva per un federalismo su base regionale. “pag. 647. Le macroregioni gli parevano costruzioni artificiose e altrettanto innaturali gli sembravano le province. Solo “la regione è in Italia una entità morale, etnica, linguistica e sociale, adatta a diventare unità politica“. Della vivacità di queste entità è prova l’organizzazione dell’esercito, che Lussu ben conosceva, da gran capitano quale fu. Ebbene, proprio per il maggior rendimenrto in guerra si è deciso il reclutamento regionale. Una vera rivoluzione - osserva l’uomo di Armungia - nella tradizione delle forze armate, che ha dato buoni frutti. Ci sono poi le peculiarità economiche che producono una vita sociale distinta.
Una situazione più marcata hanno, da questo punto di vista, le due isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, “in cui il mare risolve da sé ogni posibilità di contestazioni“. Regioni dunque a base dello Stato federale, da trasformare in tante repubbliche perché queste sono dotate di statualità e sono titolari di sovranità, mentre le regioni evocano l’esitenza di un’entità superiore, lo Stato, da cui derivano le loro potestà. Una questione di sovranità dunque per Lussu la preferenza di un sistema federale rispetto a quello regionale. Parlando di “federazione” si propendeva per “uno stato federale centrale a sovranità limitata, che è il risultato dell’unione di altri stati locali, sovrani anch’essi, ma in forma minore”.
Una tradizione robusta e risalente quella federalista sarda, che tuttavia non riuscì a far breccia in Assemblea Costituuente e nella Consulta regionale sarda. «Lo Statuto che ci diedero - commentò sarcastico Lussu - somigliava a quello che i sardi avevano sognato per anni come un gatto somiglia a un leone: l’unica cosa che hanno in comune è che tutt’e due appartengono alla famiglia dei felini». Proprio così. Ma forse è qui, in questa elaborazione che si possono trovare le chiavi per una nuova riflessione e una ripartenza.


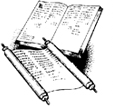

1 commento
1 Aladinpensiero
26 Giugno 2021 - 08:40
Anche su aladinpensiero online: http://www.aladinpensiero.it/?p=124244
Lascia un commento