Gianluca Scroccu
Abbiamo chiesto a Gianluca Scroccu un profilo del berlusconismo in relazione alle altre “ere” della storia d’Italia, quella giolittiana e quella fascista. Alla base c’è la convinzione che il Cavaliere non sia solo un piazzista o un narratore di barzellette, ma stia segnando nel profondo la storia e il costume italiano. Ecco l’interessante contributo del giovane storico sardo.
Su questo blog si è parlato di “era berlusconiana”. Una terminologia che in effetti risulta interessante, almeno in una prospettiva storiografica. Affiancherebbe altri segmenti importanti della recente storia italiana, come l’età giolittiana o quella mussoliniana. Accumunate dal riferimento al leader che ne impone il nome, ma non solo (si pensi solo alla schiacciante maggioranza parlamentare di cui hanno goduto tutte e tre, che per il fascismo significò, dal 1926, dittatura senza opposizione). Eppure profondamente differenti su molte questioni.
Quindici anni di giolittismo (a cui si devono sommare le parentesi del 1892-1893 e quella del giugno 1920-luglio 1921), vent’anni circa di mussolinismo e per ora, 15 anni di berlusconismo (anche se non di governo ininterrotto della propria coalizione). In realtà si dovrebbe parlare di più di vent’anni, visto che si occorrerebbe far risalire l’inizio del potere del Cavaliere ai decreti Craxi che a metà degli anni Ottanta ne sancirono il monopolio nel campo delle televisioni private.
Elemento, quest’ultimo, risultato sicuramente decisivo nella costruzione almeno della cornice ideologica e di consenso che ha permesso a Berlusconi di sopravvivere anche ai rovesci e alle sconfitte inflittegli da Romano Prodi. Un punto che permette di valutare sotto una luce diversa anche tutti gli errori di valutazione e di inazione del centrosinistra, come abbiamo potuto valutare da una bella trasmissione di Report di due settimane (si veda ancora la recente intervista al Corsera di Violante dove l’ex Presidente della Camera ha ammesso di non aver capito niente del fenomeno berlusconiano, come tanti altri dirigenti del resto; un’affermazione che ha portato un caro amico a commentare: “Ammetti di non aver compreso nulla e sei ancora lì a rilasciare interviste?”).
Una comparazione storica appare sempre rischiosa, e presuppone differenze e discontinuità. Per gli evidenti limiti di spazio, soffermiamoci ad esempio sul problema relativo al controllo del Parlamento e alla centralità della politica delle alleanze
Giolitti sale al potere dopo la crisi di fine secolo, culminata con l’assassinio di Umberto I per mano di Gaetano Bresci. Il suo successore, Vittorio Emanuele III, opta per un nuovo corso politico che abbandoni le pratiche più reazionarie. Il mondo è cambiato (si pensi soltanto al peso delle innovazioni tecnologiche dell’Ottocento, come l’elettricità) e anche la politica deve fare i conti con l’avvento della politica di massa. Giovanni Giolitti, già presidente tra il 1892 e il 1893, viene visto dal sovrano come il politico capace di dare concretezza a questo nuovo corso liberale. È direttamente Presidente del Consiglio nel biennio 1903-04, dal 1906 al 1909 e dall’1911 al 1914; di fronte a situazioni sfavorevoli, come quella relativa alla statizzazione delle ferrovie, opta per ritirate strategiche lasciando il governo a qualche collaboratore a lui fedele per poi tornare quando le condizioni si sono fatte più favorevoli. Diventa così il dominus assoluto della politica italiana del primo quindicennio del Novecento. Liberale pragmatico, vuole rendere più saldo il potere dei Savoia, rifiutando di usare il metodo reazionario. Da qui la sua politica di neutralità nei conflitti che attraversano il mondo del lavoro, le aperture ai socialisti, il rifiuto dell’uso della forza pubblica. Una politica con caute ma importanti aperture democratiche ma che non vede mai mutare gli equilibri parlamentari e che cerca prima di tutto di costituzionalizzare le forze antisistema (cattolici, nazionalisti e socialisti), per annacquarne le istanze nella maggioranza al servizio del suo disegno (tattica che non funzionerà con il fascismo), e che gli attirerà le critiche feroci di Salvemini, che lo bollerà con l’epiteto di “Ministro della Malavita” per quell’uso spregiudicato dei prefetti nel dirottare consensi verso i candidati della maggioranza governativa e per la politica protezionista rivolta contro lo sviluppo del Sud.
Il fascismo, dopo la fondazione nel marzo del 1919 dei Fasci di combattimento e la disastrosa prova elettorale alle elezioni politiche del 1919, diviene elemento centrale del sistema politico quando si presenta come braccio armato delle forze conservatrici impaurite dal “biennio rosso” e dalla crescita del movimento socialista (la fase del fascismo agrario). La vecchia classe liberale pensa di poter imbrigliare Mussolini facendolo entrare in Parlamento, ma non sa che sta firmando la condanna a morte delle Istituzioni liberali. La violenza come arma politica totalizzante, che aveva trovato nella Prima guerra mondiale la sua espressione, affiancata dal rafforzamento del controllo dello Stato sulla vita dell’individuo, diviene la cifra del mussolinismo. Ma non solo: ad essa si affianca il progetto di costruzione di un nuovo stato fascista, totalitario in quanto ambisce a costruire l’uomo nuovo che sappia incarnare, contemporaneamente, la tipologia di un’Italia classica e imperiale (il mito della romanità) e moderna (il culto del capo, l’uso della propaganda e l’organizzazione gerarchizzata della società e dell’individuo sin dall’infanzia). Dopo le elezioni dell’aprile del ’24, e la svolta dittatoriale, Mussolini non ha più bisogno del Parlamento, né di altre forze politiche alleate: lo Stato è e sarà soltanto quello fascista.
Berlusconi vive in un’epoca diversa. Il suo modello è individualista, antipolitico e antistatalista. Le analogie, più che con il fascismo, dovrebbero essere ricondotte al modello reaganiano (non a caso uno degli esponenti più importanti di quella tendenza dentro Forza Italia nel 1994 era Antonio Martino, che oggi non ricopre ruoli di primo piano). Col tempo, però, Berlusconi, ha saputo modificare, seppur in parte, i caratteri originari di Forza Italia: la nascita del PDL ha accentuato questa metamorfosi. L’avvicinamento con alcuni dei temi portati avanti dall’attuale Pontefice, o l’aver sposato le teorie neocons di Bush ne sono state la manifestazione più evidente. Per non parlare del fatto che oramai i dirigenti e gli esponenti del suo partito non sono più caratterizzati da una carica antipolitica e antipartitica come agli inizi, ma sono dei veri e propri professionisti della politica. Una circostanza visibile anche dalla conformazione geografica del voto degli italiani alla PDL alle politiche del 2008, che infatti andò male al Nord, dove perse consensi a vantaggio del Carroccio, radicandosi soprattutto nel Mezzogiorno dove si è consolidato questo nuovo professionismo, legato in maniera fideistica al capo secondo, però, una logica aziendalistica. Ed è proprio questa ideologia a condizionare le esternazioni berlusconiane rispetto al funzionamento del Parlamento, visto come un intralcio ai suoi progetti di governo. In sostanza, “il presidenzialismo dei decreti”, che di fatto abbatte la Costituzione, e che introduce nel discorso pubblico la retorica populista sull’efficienza, anche questa manageriale, sintetizzata dall’elencazione dei propri risultati sostenuta da ministri come Sacconi e Brunetta.
Naturalmente questo impianto non sarebbe potuto sopravvivere senza l’uso sapiente del potere mediatico del capo del governo, secondo quella centralità del rapporto tra comunicazione e politica, emersa del resto già durante Tangentopoli. L’età della “videopolitica” berlusconiana, un duopolio, oggi di fatto monopolio, che non è presente in nessun paese occidentale, ma che rispecchia e fa crescere identità grazie a programmi televisivi e telegiornali che costruiscono il discorso pubblico componendo quotidianamente il tessuto civico nazionale.
È grazie a questo che Berlusconi ha intercettato un elettorato di destra che le forze di centrosinistra credevano fosse scomparso dall’Italia. Un elettorato che è invece sempre stato consistente, orfano di un suo diretto rappresentante istituzionale dal ’45 e pertanto portato a votare partiti o correnti di partiti considerati meno lontani dalle proprie posizioni ma assolutamente non identificabili come soggetti di destra; congelato sino alla fine degli anni Ottanta, per poi ripresentarsi, finalmente libero, dal 1992 ad oggi sotto le insegne berlusconiane, abilissimo a dargli rappresentanza in un movimento pure assai eterogeneo, costituito da post-fascisti, post-democristiani, ex-comunisti, socialisti craxiani liberisti e statalisti. Un insieme di forze potenzialmente assai incerto nella sua base programmatica, tanto che si è reso indispensabile creare, e si rende tuttora, un denominatore comune su cui compattarlo, e cioè la totale alterità rispetto a quella che genericamente e in maniera assai semplificatoria Berlusconi definisce “la sinistra”.
Per capire come il Cavaliere abbia saputo dare forma e sostanza a queste tendenze basta leggere la seconda parte della biografia di Indro Montanelli di Sandro Gerbi e Raffaele Liucci appena uscita da Einaudi (Montanelli l’anarchico borghese. La seconda vita (1958-2001), Einaudi, 2009), che dimostra come il grande giornalista italiano sia stato per decenni portavoce (sia pur con venature libertarie e di spiccato laicismo) di un italiano medio-borghese che si esprimeva attraverso un innato qualunquismo, pulsioni individualistiche e la ripulsa verso la sinistra e la sua cultura, a cui successivamente Berlusconi ha saputo dare rappresentanza politica (e dal quale il giornalista toscano fuggì inorridito, quasi rendendosi conto di aver esercitato il ruolo di apprendista stregone nell’aver generato un mostro divenuto sempre più potente e incontrollato).
In questa breve panoramica resta da chiedersi se il berlusconismo sarà un periodo storico destinato a segnare i propri tempi ben più dell’età giolittiana o di quella mussoliniana. È difficile dirlo, anche perché la storia presenta spesso scarti improvvisi. Pensiamo al terremoto che potrebbe generare un eventuale appoggio del premier al referendum Segni-Guzzetta (che darebbe al solo PDL la maggioranza dei seggi, rendendo di fatto inutile la Lega e scatenando un conflitto nell’attuale coalizione al governo). O, ancora, alle difficoltà relative ai problemi di collegialità e di mediazione del PDL. Questo partito, del resto, sembra ora avere grandi prospettive perché è al governo e in una situazione di relativa calma sociale nonostante la crisi economica (anche qui l’ennesima anomalia italiana). Ma le frizioni, i distinguo e le prime crepe potrebbero aprirsi di fronte ad una recessione sempre più profonda, capace di coinvolgere quei ceti e quelle categorie produttive che oggi ne sostengono l’operato. Un cambio deciso della politica economica mondiale, su iniziativa americana, potrebbe ad esempio mettere a nudo le insufficienze del progetto berlusconiano. Potrebbe, siamo sempre nel campo delle ipotesi. Il problema è che non si vede un’opposizione coesa e capace di offrire un’alternativa.
Bibliografia minima:
BRUNO BONGIOVANNI, NICOLA TRANFAGLIA (a cura di), Le classi dirigenti nella storia d’Italia,
Laterza 2006;
S. CASSESE, Ritratto dell’Italia, Laterza 2001;
P. CORBETTA, M. PIRETTI, Atlante storico-elettorale d’Italia (1861-2006), Zanichelli 2009;
G. FIORI, Il venditore. Storia di Silvio Berlusconi e della Fininvest, Garzanti 2004;
E. GENTILE, Le origini dell’Italia contemporanea. L’età giolittiana, Laterza 2003;
E. GENTILE (a cura di), Modernità totalitaria, Laterza 2008;
S. GERBI, R. LIUCCI, Montanelli l’anarchico borghese. La seconda vita (1958-2001), Einaudi, 2009;
P. GINSBORG, Berlusconi. Ambizioni patrimoniali in una democrazia mediatica, Einaudi 2003;
D. LANE, L’ ombra del potere, Laterza 2006;
P. PEZZINO, Senza Stato. Le radici storiche della crisi italiana, Laterza 2002;
G. SABBATUCCI, Il trasformismo come sistema, Laterza, 2003;
M.L. SALVADORI, Storia d’Italia e crisi di regime, Il Mulino 2001;
G. SANTOMASSIMO (a cura di), La notte della Democrazia Italiana. Dal regime fascista al governo Berlusconi, Il Saggiatore, 2003;
P. SCOPPOLA, La Repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico (1945-1996), Il Mulino 1997;
A. STILLE, Citizen Berlusconi. Vita e imprese, Garzanti 2006;
F. TUCCARI, Il governo Berlusconi, Laterza 2002;
F. TUCCARI, L’opposizione al governo Berlusconi, Laterza 2004;
A. VENTRONE (a cura di), L’ossessione del nemico. Memorie divise nella storia della Repubblica, Donzelli 2006;


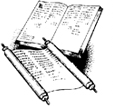

2 commenti
1 Gavino Corda
2 Aprile 2009 - 21:38
La lettura di queste note, accompagnata(suggerisco sommessamente) alla lettura del pezzo di Carlo Galli ” Senza stato…” sul n° 2 / 2009 di LImes, può permetterci di spaziare su un orizzonte, all’interno del quale, forse, c’è anche la nostra isola, con i suoi personaggi e le sue vicende-
2 Giambattista
25 Aprile 2009 - 01:44
Buona ricostruzione e spunti interessanti. Vi suggerisco di aggiungere anche la lettura del libretto di Santarelli sul profilo del berlusconismo. Ciao
Lascia un commento